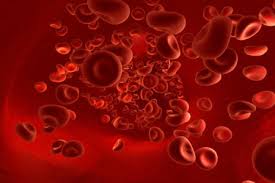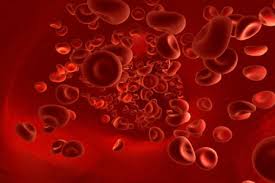Prima leggi: PAPÀ, “TENTATOSUICIDIO?” (parte 1)
Avevo pranzato a casa. Quel venerdì pomeriggio non lavoravo. Poco prima di cena sarei partito per Nizza con Guendalina e il pomeriggio a casa mi serviva per prepararmi la borsa e sbrigare alcune incombenze. Dopo pranzo stavo chiacchierando con la mamma, seduti sulle poltrone di vimini del terrazzino del salotto. Un posto ambitissimo. Le poltrone comode come troni. Il terrazzo costantemente battuto da una brezza delicatissima. D’estate era il luogo più fresco dell’appartamento. E, aprendo le vetrate, il terrazzo diventava un’estensione del salotto.
Lo scorgo con la coda dell’occhio. “Papà! – urlo, mentre scatto verso la libreria bianca dall’altra parte del salotto – cosa cazzo stai facendo!?”. Lo raggiungo di fronte al vassoio delle bottiglie di superalcolici che, in casa nostra, hanno sempre avuto una funzione ornamentale.
“Metti giù quel bicchiere!”. Le mani indebolite dalla CIDP mi impediscono di strappargli il bicchiere di whisky, come vorrei fare. “Metti giù quel cazzo di bicchiere!”. Sto urlando tutta la mia frustrazione. Voleva che lo vedessimo. I superalcolici e il fumo. Stava alzando il livello del ricatto.
Papà mi fissa con aria di sfida. “Sennò…”.
“Codardo”. La mia voce è un sibilo. “Affronta il problema da uomo, invece di ricorrere a questi ricattini”. Sottolineo con enfasi la parola “uomo” per dirgli che si sta comportando da tutt’altro.
Poi, tutto avviene al rallentatore. Papà arretra il braccio destro, teso. Carica la spalla. Sta per partire la sberla più poderosa che mi abbia mai dato. Potrei tranquillamente pararla. Oppure fare un passo indietro e schivarla. Scelgo di rimanere immobile. Di prenderla. Di ricevere il colpo per dire a papà che la partita si è chiusa. Non abbiamo più paura della sua prepotenza. A scanso di equivoci metto le mani in tasca. Nel caso l’istinto mi dovesse far reagire come era capitato alcuni anni prima quando aveva colpito Marta. Mentre il braccio sta fiondando verso la mia guancia sinistra, fletto le ginocchia leggermente per assorbire meglio il colpo.
La sberla è perfetta. La botta è potentissima. Pesantissima. Occhio, guancia e orecchio in un solo colpo. Barcollo leggermente. L’occhio sinistro lacrima, l’orecchio fischia. Lo sguardo è rimasto fisso su papà. La mamma poco lontana esterrefatta. Riprendo sibilando.
“Bravo. Cosa hai ottenuto? Niente”. Papà si siede sul divano. “Sai cosa mi fa incazzare? Mi fa incazzare che sono due mesi che mi rompi i coglioni per cercare di convincermi a dire alla mamma di smettere di lavorare. E invece di sforzarti di capire o quanto meno accettare che la mamma fa bene a lavorare per lei, perché ne ha bisogno, non sai far altro che ricattarci con il pericolo di un nuovo infarto”.
“Cosa?”. È la mamma ad intervenire. “Cosa hai fatto negli ultimi due mesi?”. È sorpresa e delusa allo stesso tempo.
Papà guarda la mamma con aria di sufficienza.
“Diglielo”. La sorpresa della mamma sta virando lentamente verso la rabbia.
Papà la guarda quasi indifferente.
“Diglielo, o glielo dico io”, intima la mamma.
Sono confuso. Non capisco cosa stia succedendo. Sicuramente non una cosa buona.
Papà rimane impassibile.
La mamma mi guarda. “Quando ho incominciato a lavorare e lui ha incominciato tutte le notti a parlarmi per convincermi a smettere, mi ha detto anche che non dovevamo coinvolgerti perché con la tua malattia hai bisogno di serenità…”.
Avrei preferito ricevere un’altra sberla perfetta. La potenza con cui mi colpisce la notizia è devastante. Chiedo serenità in famiglia, soprattutto a papà, da quando sono stato aggredito dalla CIDP. Nulla. Ho appena scoperto che proprio mio papà ha usato la mia malattia per raggiungere un suo scopo. Per allontanarmi dalla mamma ha messo sul campo da gioco la mia serenità. Mi ha usato. Ha usato la mia malattia.
“Mi hai usato. Hai usato la mia malattia”. L’incredulità si sta trasformando in rabbia.
Papà tace. Guardando fisso davanti a se.
“Dimmi qualcosa…”.
Tace. Mi avvicino.
“Devi dirmi qualcosa!”. L’urlo lo fa sobbalzare.
Continua a tacere.
Parte d’istinto. Il braccio destro scatta verso il viso di papà. Un movimento goffo. Lo colpisco con la mano ciondolante, morbida e leggera. Colpisco. Colpisco. E colpisco. Ogni colpo accompagnato da un urlo: “Hai usato la mia malattia!”. Papà non si difende. A quello ci pensa la CIDP. Subisce passivamente.
Sto per uscire. Destinazione Nizza. Papà è ancora seduto sul divano. Mamma è già uscita. Raggiungerà sua sorella sul lago di Como per il fine settimana. Alessandro e Marta sono fuori per il weekend già dalla mattina. “Per tutta la nostra vita ci hai puniti con i tuoi silenzi. Ora capirai cosa significa. Con me hai chiuso. Non ti sto punendo. Non riconosco un padre che per tornaconto usa la malattia del figlio contro la propria moglie”. Ed esco.
Lunedì mattina arrivo in ufficio direttamente da Nizza. La signora Duncan mi avvisa di chiamare casa. Risponde la mamma.
“Papà è al pronto soccorso per problemi al cuore”.
“Infarto?”
“No”.
“Bene. Siamo al terzo livello del ricatto”.
L’infarto arriva all’alba di martedì. Passo la mattina rincorso dai dubbi. Ricatto? Realtà? Vado? Lo ignoro? Decido di andarlo a trovare. Prima di entrare spiego la situazione tra me e il papà al cardiologo. Non vorrei che l’emozione di vedermi entrare gli provocasse qualcosa. Il cardiologo mi precede. E mi annuncia. Entro. Nel letto l’ombra di mio padre. L’uomo grande e grosso, prepotente e sicuro non c’è. I suoi occhi grigi sono smarriti. Si aggrappano ai miei. Gli prendo la mano.
“Sono un uomo finito”. La sua voce è un sussurro.
“Non ci pensare neanche. Rimettiti che ci rifacciamo il Passo della Forcola”.
“Va bene”.
Stiamo mentendo entrambi. Ed entrambi lo sappiamo.
Mercoledì. Sono da poco passate le due. Il silenzio della notte è squarciato dallo squillo dirompente del telefono di bachelite. Apro gli occhi. Ci siamo. Risponde la mamma. Dall’altra parte l’unità coronarica dell’ospedale San Raffaele: “Venite in ospedale, ci sono delle complicazioni”. È il messaggio in codice. Un quarto d’ora dopo siamo tutti in reparto. E papà se ne è già andato.
Se ne è andato come era vissuto. In conflitto.
—————————
Maggio 2010. L’Inter vince la Champions League dopo oltre quaranta anni di attesa. Nei quarti di finale l’Inter batte 3 a 1 il Barcellona, la squadra più forte del mondo, in una partita epica. Uscendo dallo stadio non riesco a non pensare a papà, alla sua immensa passione per i colori nerazzurri. “Cazzo! Dovevi esserci…”. Compro la sciarpa commemorativa della partita. E dopo la vittoria finale la porto al cimitero. Nelly la annoda alla tomba mentre fisso la lastra di granito: “Cazzo, papà! È stato fantastico”.
(Luglio 1992)