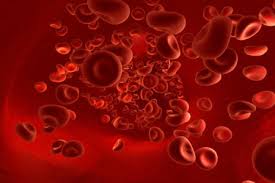
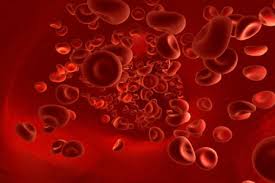
LA PREPARAZIONE AL TRAPIANTO: IL CATETERE VENOSO CENTRALE
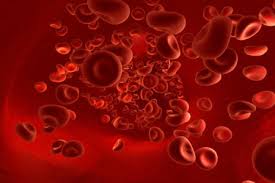

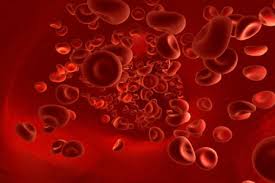
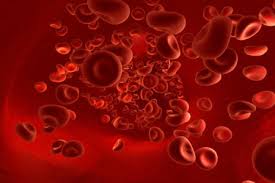
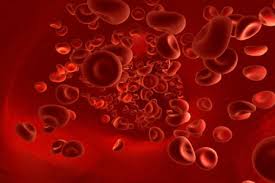
In passato le cellule staminali venivano prelevate direttamente dalle ossa del bacino. Espiantate in anestesia generale. Oggi, grazie a una tecnica chiamata Leucaferesi, le cellule staminali sono raccolte dal sangue periferico. Prima della Leucaferesi il paziente viene sottoposto ad un dosaggio di chemioterapia. Al chemioterapico segue la somministrazione sotto cute di un farmaco (Lenograstim) che stimola il midollo osseo a produrre cellule staminali del sangue. Dal midollo osseo le cellule staminali passano al sangue. È il momento della Leucaferesi, il prelievo.
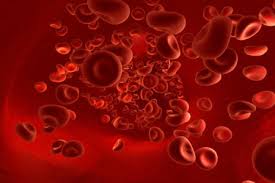
Tentativo 1
“Riccardo, non ti cambiare la maglietta con cui dormi per quindici giorni. Poi dammela”.
“E…”, rispondo a papà invitandolo a dare seguito all’assurda richiesta con una spiegazione.
“Tu non ti preoccupare, dormi quindici giorni con la stessa maglietta e poi dammela”.
“Ottavio, vieni con me. Ti porto da uno bravo che risolve tutti i problemi”.
“Ottavio, dice che devi portargli tuo figlio”.
“Non posso, non gli concedono il visto di entrata”. La Libia era in uno dei suoi periodi di isolazionismo.
“Allora dice di portargli una maglietta dove abbia dormito per almeno quindici giorni”.
“Ha toccato la maglietta e ha capito tutto. Dice che hai un problema nervoso. Si risolve prendendo olio di semi di arachidi e un infuso a base di cespuglio del deserto”. Che papà, diligentemente, si era fermato a raccogliere appena uscito dalla tenda.
Il pianerottolo è anonimo. Come lo è il palazzo di via Palmanova. È anonimo l’appartamento. E la signora che ci riceve. A dire la verità non ho capito bene cosa siamo venuti a fare. “Mi ha garantito che se c’è qualcuno che ti può dire cosa sta succedendo è proprio lei”. Quest’incontro l’aveva suggerito a papà il medico che abitava sotto di noi. Si era fatto convincere senza sforzi. E io mi ero lasciato trascinare.
“Si, si può fare. Userò i tarocchi. Con permesso”. Si alza ed esce dalla stanza.
“Cazzo papà! Una cartomante! Mi hai portato da una cartomante…”. La mia indignazione, le mie urla, sono strette in un sussurro.
“Non fare il pirla, Riccardo. Per piacere…”, contro sussurra papà per metà scusandosi e per l’altra metà minacciandomi.
“Si, si chiama Valeria”. E racconto sommariamente della storia con Valeria. Fatta di corna che ho portato con poca dignità, tradimenti e sofferenza.
“Infatti, lo dicono anche le carte. E tu l’hai trattata male?”
“Si. Alla fine si”.
“Ecco, lo dice questa carta”, mi conferma la signora indicando un tarocco. Poteva indicarne uno diverso che per me valeva tanto quanto. Si concentra sulle carte. Mi guarda fisso negli occhi. E con fare solenne conclude.
“Valeria ti ha fatto il malocchio perché l’hai trattata male. Te l’ha fatto in Toscana”.
Vorrei tanto ignorarla. Ma mi scappa una domanda. “Quando?”
“Tre anni fa. Era dicembre”.
“È sicura?”
“Le carte non sbagliano mai”.
“Bene. Bene”. Faccio una pausa per catturare tutta l’attenzione della signora. “Tre anni fa Valeria e io non ci conoscevamo”.
“Certo – risponde prontamente la signora – te l’ha fatto in modo che siattivava se la trattavi male”.
Non riesco più a stare zitto. “Cos’è? Un malocchio preventivo al buio?”
“Esatto… In che senso al buio?”. La signora è visibilmente confusa.
Prima leggi: TRAPIANTO DIMIDOLLO, LA CADUTA
Ho appena finito di raccontare a Il Prof. della caduta di ieri mattina. Momento per momento, l’ho raccontata nei particolari.
“Dieci, forse 15%”, risponde Il Prof con l’espressione di chi sta misurando il rischio nel modo più accurato possibile.
“Il punto è proprio questo professore. Io quella scala la faccio tutti i giorni, quattro volte al giorno. E non ho intenzione di smettere. Si rende quindi conto che il 2% diprobabilità di morte con il trapianto di midollo è un rischio irrisorio”.
Il volto del Prof. si oscura. Fissa un punto immaginario davanti a sé. Riflette e poi mi fissa. I suoi occhi piantati nei miei.
“Si rende conto del rischio? Il 2% è tanto”.
“Professore. Le dico come la vedo. Oramai ci conosciamo. E sa che non mi fermo di fronte a nulla. Ieri ho rischiato di ammazzarmi e sono tornato a lavorare un attimo dopo. Questo è un punto. Ma la cosa più importante è questa. Tutti dobbiamo morire, prima o poi. Io sono tra quelli che, con ogni probabilità, ci arriverà prima. Sto peggiorando drasticamente. E se continuo a peggiorare così arrivarci è una questione di quanto? Pochi anni? Bene. Detto questo, io posso fare solo una cosa. Scegliere come arrivarci. Tra pochi anni immobilizzato in un letto oppure tra pochi mesi con il trapianto di midollo, ma combattendo. Io decido di combattere la CIDP con il trapianto. Professore, proviamo… Se poi va anche bene … “.
Il Prof si ritira nei suoi pensieri. Poi si rivolge a me preoccupato. “Proviamo Taverna”.
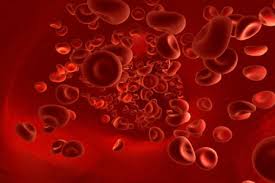
PRIMA LEGGI: Trapianto dimidollo, razionale terapeutico e probabilità di morte
“Buongiorno”, rispondo a Enza, la signora che tre volte alla settimana fa i mestieri in casa. Sono appena sbarcato nel super attico. Prendo i tempi per la rotazione sulla mano destra, il mio perno. La fisso per controllarla. Stacco la mano sinistra dal suo muricciolo. Nello stesso istante i miei occhi vengono catturati da un post-it sulla mia tastiera. Un messaggio della cugina di Romana. La mano destra, il mio perno, scivola indietro verso la scala. Non me ne accorgo. Perdo l’equilibrio. Poi, tutto succede in un attimo. Un lungo, tremendo attimo.
“Ferme!”. Urlo l’ordine secco.
“Ferme – continuo persuasivo – non toccatemi. Lasciatemi capire come sto”.
Ascolto il mio corpo. Osso dopo osso. Muscolo dopo muscolo. Nessun dolore. Mi muovo lentamente. Prima una gamba. Poi l’altra. Un braccio. Poi l’altro. Il busto. Le spalle. Il collo. La testa. Ancora nessun dolore. Sono stato fortunato. O bravo. O bravo e fortunato. Non importa. Spiego a Marta e alla signora come aiutarmi. Mi siedo sul pianerottolo. Sospiro. Mi appoggio ai gradini della seconda rampa. E gattono verso il super attico.
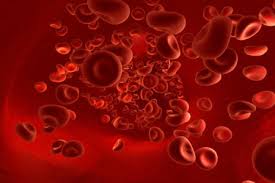
Si, ho fatto anche questo. Mi sono fatto esorcizzare. Non perché ci creda. Il mio rapporto con Dio in quel periodo era sostanzialmente nullo. Non ci credevo. E non per colpa della CIDP. Ho accettato di farmi esorcizzare per non sentire più la mamma insistere.
“E chi è?”. Rispondo tanto per fare conversazione.
“È un vescovo. Una delle pochissime persone autorizzate dal Vaticano a compiere esorcismi…”.
Capisco al volo. “Dai mamma, non vorrai mica che…”.
“Perché no? Cosa ti costa?”
“Niente… Non mi piacciono queste cose, lo sai…”.
“Ma fallo, non ti costa niente. Almeno ci togliamo lo scrupolo. Escludiamo questa eventualità”. L’eventualità del malocchio. Dell’essere posseduto.
PRIMA LEGGI: L’Inizio… Ilcortisone e l’abbandono della medicina tradizionale

Il modello è consolidato. Ricovero nel tardo pomeriggio del venerdì. Dimissioni la domenica sera. In mezzo due giorni di immunoglobuline endovena. Tutto procede. Anzi no. La domenica pomeriggio ho uno sbalzo di pressione. Me dimettono lunedì mattina.

“Cazzo…”. Incomincio a perdere la pazienza. È il quarto tentativo. Fallito. Come i precedenti. Tutte le volte lo spazzolino da denti è caduto sul fianco. Urtato dal tubetto del dentifricio.
Lo specchio non mi tradisce mai. Ogni mattina, quando ci incontriamo, mi scruta con discrezione, mi guarda dentro e formula la sua sentenza. Freddo, cinico, onesto. Lo specchio del bagno mi restituisce quello che sono, dentro. E lo fa con un gesto semplice e profondo. Mi guarda negli occhi. Se abbasso lo sguardo, se sfuggo a me stesso, e mi capita, il significato è inequivocabile: devo porre rimedio.