Archivi tag: CIDP
MIA SORELLA SI DISIMPEGNA MENTRE … (Parte 2)
MIA SORELLA SI DISIMPEGNA MENTRE … (Parte 1)
UNA CADUTA, LA REAZIONE DI NELLY
MARCONE
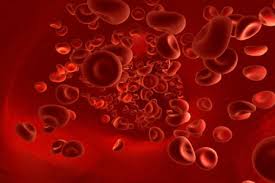
LA PREPARAZIONE AL TRAPIANTO: IL CATETERE VENOSO CENTRALE
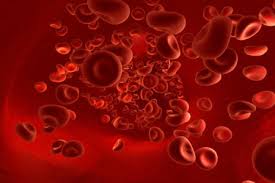
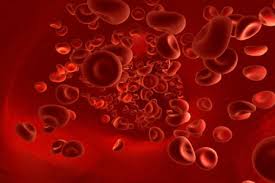
TRAPIANTO AUTOLOGO DI CELLULE STAMINALI EMATOPOIETICHE: IL MIO TRAPIANTO
In passato le cellule staminali venivano prelevate direttamente dalle ossa del bacino. Espiantate in anestesia generale. Oggi, grazie a una tecnica chiamata Leucaferesi, le cellule staminali sono raccolte dal sangue periferico. Prima della Leucaferesi il paziente viene sottoposto ad un dosaggio di chemioterapia. Al chemioterapico segue la somministrazione sotto cute di un farmaco (Lenograstim) che stimola il midollo osseo a produrre cellule staminali del sangue. Dal midollo osseo le cellule staminali passano al sangue. È il momento della Leucaferesi, il prelievo.
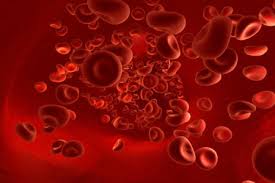
MARTA E ALESSANDRO RITORNANO.
Prima leggi: L’EREDITÀ DI PAPÀ: LA DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA
MEDICINA ALTERNATIVA: TENTATIVI GROTTESCHI
Tentativo 1
“Riccardo, non ti cambiare la maglietta con cui dormi per quindici giorni. Poi dammela”.
“E…”, rispondo a papà invitandolo a dare seguito all’assurda richiesta con una spiegazione.
“Tu non ti preoccupare, dormi quindici giorni con la stessa maglietta e poi dammela”.
“Ottavio, vieni con me. Ti porto da uno bravo che risolve tutti i problemi”.
“Ottavio, dice che devi portargli tuo figlio”.
“Non posso, non gli concedono il visto di entrata”. La Libia era in uno dei suoi periodi di isolazionismo.
“Allora dice di portargli una maglietta dove abbia dormito per almeno quindici giorni”.
“Ha toccato la maglietta e ha capito tutto. Dice che hai un problema nervoso. Si risolve prendendo olio di semi di arachidi e un infuso a base di cespuglio del deserto”. Che papà, diligentemente, si era fermato a raccogliere appena uscito dalla tenda.
Il pianerottolo è anonimo. Come lo è il palazzo di via Palmanova. È anonimo l’appartamento. E la signora che ci riceve. A dire la verità non ho capito bene cosa siamo venuti a fare. “Mi ha garantito che se c’è qualcuno che ti può dire cosa sta succedendo è proprio lei”. Quest’incontro l’aveva suggerito a papà il medico che abitava sotto di noi. Si era fatto convincere senza sforzi. E io mi ero lasciato trascinare.
“Si, si può fare. Userò i tarocchi. Con permesso”. Si alza ed esce dalla stanza.
“Cazzo papà! Una cartomante! Mi hai portato da una cartomante…”. La mia indignazione, le mie urla, sono strette in un sussurro.
“Non fare il pirla, Riccardo. Per piacere…”, contro sussurra papà per metà scusandosi e per l’altra metà minacciandomi.
“Si, si chiama Valeria”. E racconto sommariamente della storia con Valeria. Fatta di corna che ho portato con poca dignità, tradimenti e sofferenza.
“Infatti, lo dicono anche le carte. E tu l’hai trattata male?”
“Si. Alla fine si”.
“Ecco, lo dice questa carta”, mi conferma la signora indicando un tarocco. Poteva indicarne uno diverso che per me valeva tanto quanto. Si concentra sulle carte. Mi guarda fisso negli occhi. E con fare solenne conclude.
“Valeria ti ha fatto il malocchio perché l’hai trattata male. Te l’ha fatto in Toscana”.
Vorrei tanto ignorarla. Ma mi scappa una domanda. “Quando?”
“Tre anni fa. Era dicembre”.
“È sicura?”
“Le carte non sbagliano mai”.
“Bene. Bene”. Faccio una pausa per catturare tutta l’attenzione della signora. “Tre anni fa Valeria e io non ci conoscevamo”.
“Certo – risponde prontamente la signora – te l’ha fatto in modo che siattivava se la trattavi male”.
Non riesco più a stare zitto. “Cos’è? Un malocchio preventivo al buio?”
“Esatto… In che senso al buio?”. La signora è visibilmente confusa.
LA PLEURITE DELLA MAMMA
Prima leggi: L’EREDITÀ DI PAPÀ: LA DISGREGAZIONE DELLA FAMIGLIA

